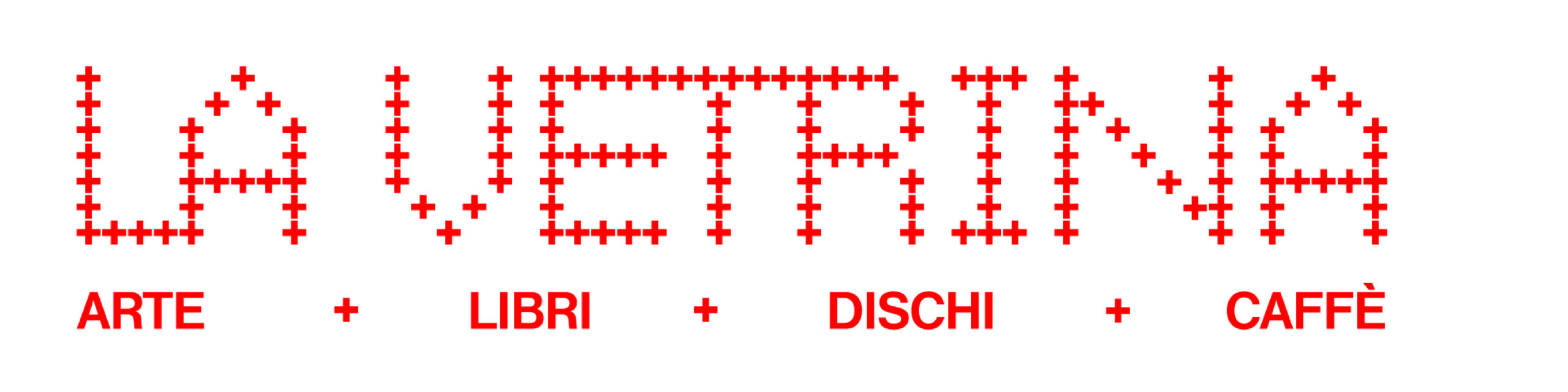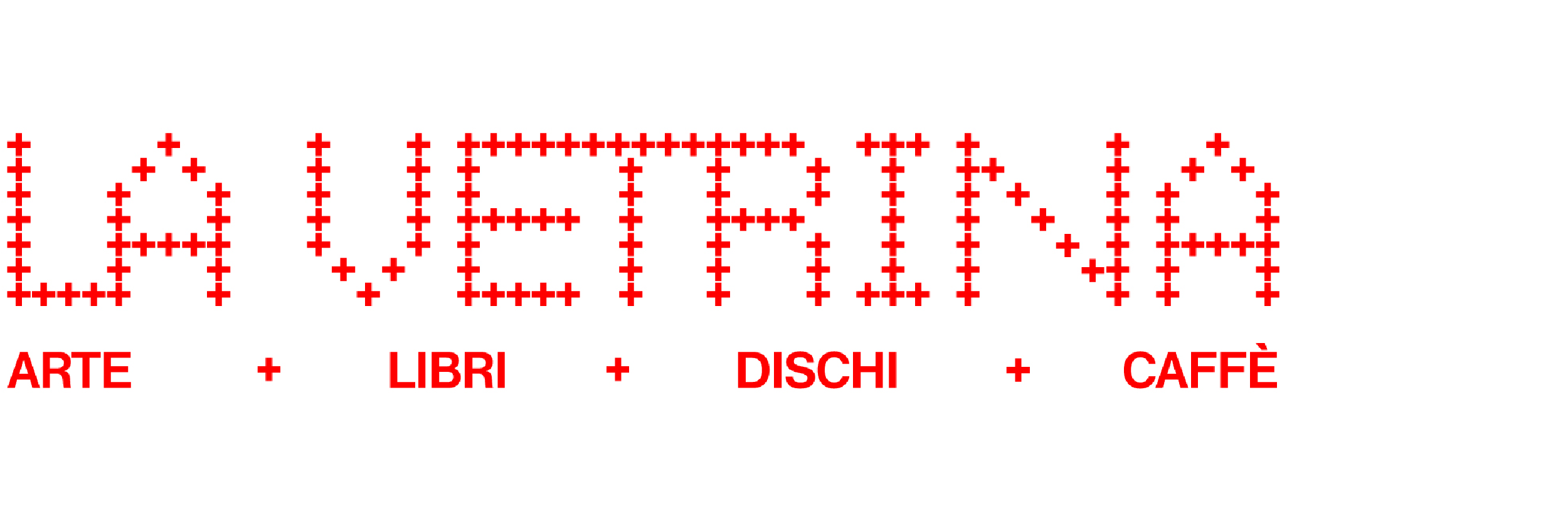1
Il progetto 50 Hertz, presentato alla Vetrina di Venezia, è un’installazione sonora che unisce suono e ceramica. Per farla risuonare occorrono anche acqua ed elettricità.
Spiegaci meglio Salômé: hai studiato musica e ti sei formata come violinista. La ceramica è un’altra freccia al tuo arco. Come ti è venuta l’idea di combinare questi elementi?
Durante i miei studi di violino, ero affascinata tanto dal suono prodotto dalle corde aperte quanto dalla quantità di note che lo strumento poteva suonare. Più tardi, mentre studiavo arte e design, ho ripreso in mano il mio strumento per integrarlo in una pratica visiva e sonora più sperimentale che già prefigurava l’universo sonoro di 50 Hertz e, più in generale, la mia pratica della musica drone. Il mio progetto di diploma è stato il proseguimento di questa ricerca attraverso un’installazione sonora, che ho continuato a sviluppare come performance.
A quel punto, mi sono rivolta alla ceramica per diversi motivi: volevo forme organiche con cui potessi interagire e che fossero della dimensione giusta per le mie mani; avevo bisogno delle proprietà conduttive e isolanti dell’argilla e degli smalti per sviluppare un repertorio di gesti e contatti intorno alla ceramica; infine, al di là dell’aspetto pratico, la ceramica mi ha permesso di sviluppare una scenografia specifica attraverso scelte estetiche.
Al di là della pratica stessa, questa complicità tra suono e ceramica rivela un dialogo più profondo tra materia e vibrazione. L’argilla, elemento tellurico, conserva al suo interno la memoria del gesto e del fuoco; incarna una materialità densa e tangibile. Il suono è immateriale, fugace, sfuggente, ma possiede un potere vibratorio che attraversa corpi e spazi. Combinando i due elementi, 50 Hertz riunisce l’inerzia minerale e la fluidità vibratoria, il solido e l’invisibile. Con Flora Basthier, artista e ceramista sonora, stiamo creando un label che riunisce progetti che riflettono questa problematica.
2
La tua installazione viene categorizzata come “musica drone”. Potresti darci una definizione di questo genere?
Secondo me la musica drone è una pratica basata su suoni continui che evolvono gradualmente in termini di volume, durata e aggiunte o sottrazioni. È più un’esperienza sensoriale che melodica. In 50 Hertz, strati sostenuti rivelano armoniche, variazioni di fase, dissonanze e strutture tra le frequenze. Qui, il drone agisce come una massa sonora avvolgente, che incoraggia l’introspezione e un ascolto più ampio.
3
Ritieni che il pubblico reagisca con forza alla tua installazione 50 Hertz, che hai sottotitolata Le Chant du Spectre? Dobbiamo prepararci a rabbrividire, tremare o anche di più?
Le reazioni dipendono dalla curiosità e dalla sensibilità di ciascuno. A volte, di fronte alla mancanza di comprensione del funzionamento del dispositivo, alcune persone interpretano i suoni attraverso le proprie conoscenze e la propria immaginazione, dando vita a storie meravigliose. L’installazione e la performance aprono uno spazio per i sensi, l’immaginazione e la contemplazione: ognuno proietta su di essa le proprie percezioni.
Il titolo 50 Hertz si riferisce alla frequenza fondamentale della corrente alternata domestica in Europa. Quando viene captata da un impianto audio (altoparlanti e subwoofer), questa frequenza si manifesta come un rumore residuo continuo, spesso definito ronzio. Il sottotitolo Le Chant du Spectre si riferisce alla radiazione elettromagnetica prodotta dai tubi al neon, che fa “cantare” il ronzio: questo campo elettromagnetico interferisce con il segnale a 50 Hz e provoca variazioni di fase, ampiezza e spettro armonico.
Queste modulazioni alterano sia il timbro che il volume del ronzio, trasformando una semplice frequenza parassita in un materiale sonoro in evoluzione. Il titolo 50 Hertz, Le Chant du Spectre si riferisce poeticamente a questo fenomeno fisico e al suo dispositivo, conferendogli una dimensione sensibile e immaginaria.
4
Attraverso il tuo lavoro promuovi l’“ecologia acustica”, che consente un ascolto profondo, il deep listening. Quale connessione desideri promuovere tra questi due termini, ecologia e acustica?
Per me, l’“ecologia acustica” consiste nel riconoscere che il suono è un mezzo che condividiamo, uno spazio sensibile in cui siamo costantemente immersi. Si tratta di diventare consapevoli di questo ambiente sonoro, percepirne le sfumature e rilevare ciò che viene aggiunto o cancellato sotto l’effetto del rumore dominante. L’ascolto profondo, il deep listening così come concepito da Pauline Oliveros, è in linea con questa idea: è una pratica di consapevolezza ampliata che ci insegna ad ascoltare i suoni marginali e i silenzi, ad accogliere le risonanze profonde e ad aprirci a una percezione più raffinata. Ma al di là di un atteggiamento contemplativo, vedo in esso anche un potenziale critico. In Guerre sonore, Steve Goodman dimostra come le frequenze possano diventare strumenti di controllo o di mobilitazione affettiva, sia che vengano utilizzate in un contesto militare, mediatico o di intrattenimento. Ciò significa che il suono non è neutro: ha un potere politico, capace di agire sui nostri corpi, sulle nostre emozioni e sui nostri comportamenti.
L’ecologia acustica, combinata con l’ascolto profondo, diventa così uno strumento: ci permette di ritrovare la consapevolezza della nostra immersione nelle vibrazioni, di percepire certe forme di alienazione sonora, di aprire possibilità di emancipazione e di condividerle collettivamente. È attraverso questo spettro che cerco, nella mia piccola misura, di mantenere l’equilibrio tra la sensibilità poetica del suono e la consapevolezza del suo potere critico.