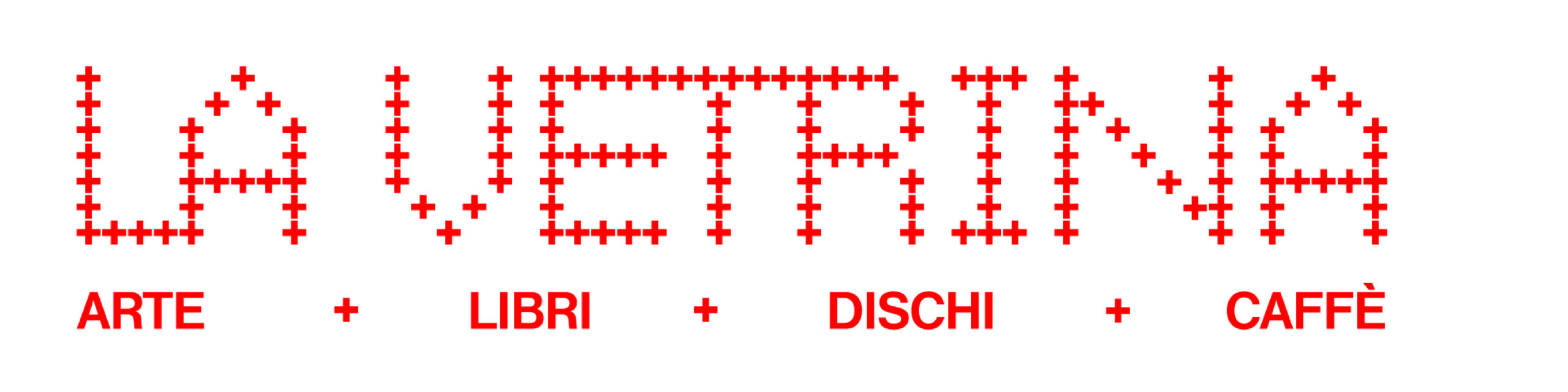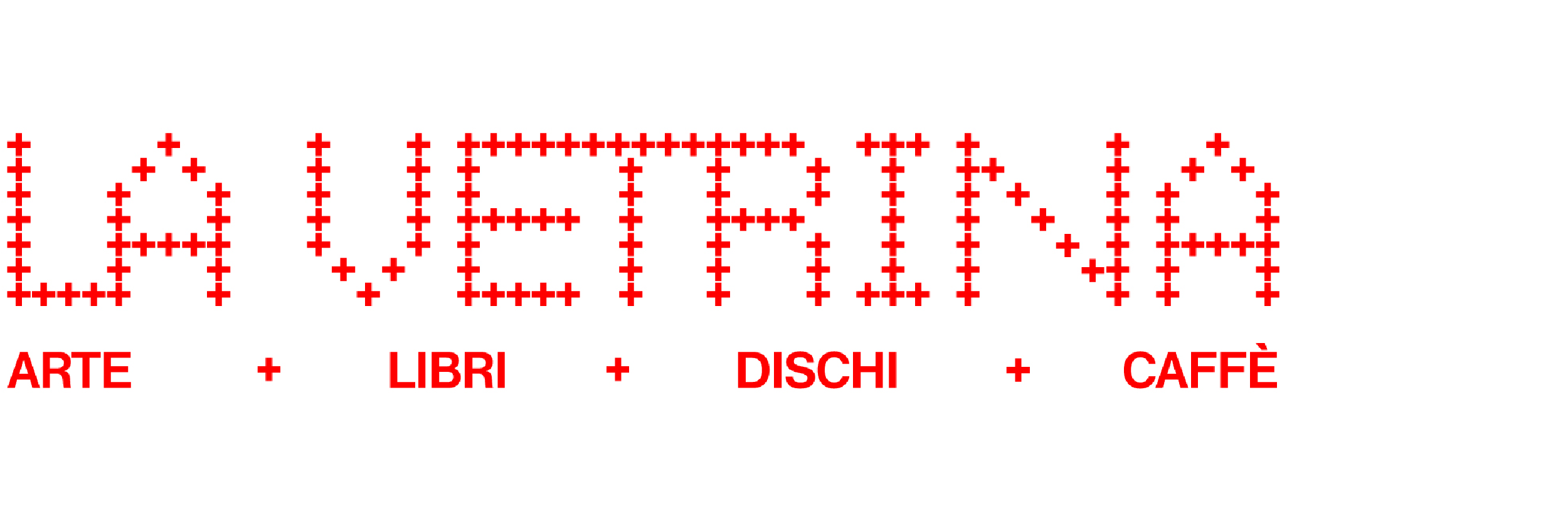1
Il suo libro inizia portando il lettore con lei nel cuore del Sahara algerino. È stato il contatto diretto con la sabbia che l’ha portata a mettere in discussione il cemento?
Inizio questa narrazione globale con un’esperienza personale. Durante un viaggio nel Sahara algerino, precisamente nella palmeraia di Timimoun, un cliente mi ha chiesto di progettare una guesthouse nel cuore dell’oasi. Scoprendo il luogo, ho provato subito un certo disagio all’idea di costruire lì. I cantieri si moltiplicavano e i blocchi di cemento stavano gradualmente sostituendo i mattoni di adobe, terra cruda utilizzata da secoli nella regione e nel mondo. Mi è sembrato evidente che, in questo ambiente, l’adobe fosse un materiale molto più adatto.
Ho anche preso coscienza dei miei limiti: non ero mai stata formata per lavorare con questo materiale. Durante questo soggiorno, ne ho scoperto le qualità: la capacità di essere riciclato all’infinito, di regolare l’umidità e la temperatura interna. È sorprendentemente fresco all’interno di una casa in adobe.
Ho quindi cercato un muratore che sapesse ancora costruire con l’adobe. Ma le persone che ho incontrato hanno cercato di dissuadermi: « La terra è per i poveri », mi dicevano. Mi proponevano invece blocchi di cemento, presentati come più solidi e moderni.
Ho allora scoperto che questi blocchi erano fatti con cemento importato da Algeri e sabbia… anch’essa proveniente dalla capitale, a oltre 1.200 chilometri di distanza. La sabbia del deserto, essendo troppo fine, è inadatta per il cemento.
Mi sono trovata di fronte a questa contraddizione: costruire con il cemento nel deserto, in nome della modernità, per realizzare edifici che avrebbero bisogno di essere climatizzati… e talvolta persino riscaldati. È da questa esperienza che sono nati i miei primi dubbi.
2
Come architetta, si confronta con il grande prestigio della costruzione in cemento. Affronta questa sfida due volte: prima come studentessa di architettura, e poi, dopo gli studi, con i clienti che deve convincere dell’esistenza di altre soluzioni?
Il cemento armato ha plasmato il XX secolo. Composto da calcare, argilla e sabbia—materiali disponibili su ogni continente—può essere colato in stampi, assumendo qualsiasi forma, e quando combinato con l’acciaio, permette realizzazioni strutturali che hanno rivoluzionato l’architettura. Rispetto alla pietra, più restrittiva nell’estrazione e nella messa in opera, il suo successo è comprensibile.
Non rinnego l’eredità del cemento né quella della modernità, ma forse lo abbiamo amato troppo: oggi, l’80% delle costruzioni è realizzato con esso. Durante i miei studi, questo materiale era dato per scontato, presentato come l’unica soluzione per realizzare gli spazi liberi, fortemente influenzati dal pensiero corbusiano degli anni ’20, che disegnavamo. Il cemento a vista era persino un ideale.
Solo dopo i miei studi ho iniziato a mettere in discussione questo dominio. Ho preso coscienza del suo costo ambientale: l’impronta di carbonio massiccia della produzione di cemento, l’esaurimento di risorse come la sabbia, l’obsolescenza del binomio cemento-acciaio e la difficoltà di riciclare queste strutture a fine vita.
Ho quindi intrapreso delle formazioni in altre pratiche, esplorando alternative al modello dominante. Come architetta, e ora come insegnante, mi sforzo di sensibilizzare i miei clienti e studenti sulle questioni legate ai materiali—al loro impatto, sia ambientale che sociale, sui territori. Data la forza delle normative, l’inerzia delle abitudini e l’immaginario industriale ancora molto presente, il percorso rimane difficile. Ma è necessario, e non dobbiamo arrenderci.
3
Pietra, paglia, legno, terra cruda… ha una soluzione preferita?
Non ho preferenze in termini di materiali: ogni risposta è altamente locale, dipendente dalla disponibilità di risorse e dal know-how esistente. Non si può semplicemente sostituire un materiale con un altro e pensare che il problema sia risolto.
La globalizzazione, così come la supremazia di alcuni materiali come il cemento, o prodotti derivati dalla petrolchimica—collanti, isolanti in polistirene, membrane plastiche—hanno profondamente modificato il nostro modo di costruire. I nostri edifici oggi consistono in una stratificazione di materiali provenienti da tutto il mondo, spesso incollati tra loro, rendendo qualsiasi riparazione o sostituzione estremamente difficile.
In risposta, sostengo un’architettura più frugale, una costruzione semplificata, attenta all’origine dei materiali, alla loro integrazione in filiere corte, ai loro metodi di estrazione socialmente responsabili e alla loro messa in opera. Una costruzione che reintegra il lungo termine, permettendo la riparazione, l’adattamento e, soprattutto, il prolungamento della vita degli edifici.
Nel XX secolo, abbiamo deciso di costruire per 50 anni. Questo è ovviamente troppo breve. Storicamente, le città si sono sempre costruite sulle tracce, rovine e strutture dei loro predecessori—senza ricorrere alla discarica.
4
Il cemento non è immune al mar-keting ecologico ingannevole… nel suo libro affronta il « cemento verde ». È puro greenwashing?
Non esattamente. Numerose ricerche sono condotte da laboratori universitari e da alcuni dipartimenti R&D dei grandi gruppi cementieri per ridurre l’impronta di carbonio del cemento. L’esempio più convincente, a mio avviso, è lo sviluppo del cemento LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) da parte dell’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, che offre prospettive promettenti, con una potenziale riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 40%. Tuttavia, alcune iniziative, come la gamma ECOPact di Holcim, pur dichiarando una significativa riduzione dell’impronta di carbonio, sollevano interrogativi. È essenziale esaminare attentamente queste affermazioni per distinguere i reali progressi dalle strategie di greenwashing.
Sono state sollevate critiche riguardo alla trasparenza e all’efficacia reale di alcune soluzioni cosiddette « verdi ». Ad esempio, organizzazioni ambientaliste, come il Carbon Disclosure Project, hanno assegnato a Holcim un punteggio di « D » per la sua performance in materia di sostenibilità, evidenziando una carenza di investimenti adeguati per ridurre le emissioni dirette dei suoi impianti a livello globale. Inoltre, l’utilizzo di scorie d’altoforno, un sottoprodotto dell’industria siderurgica con un bilancio di carbonio molto basso a causa di una decisione contabile europea, solleva interrogativi. Alcune aziende importano anche clinker, componente principale del cemento, da paesi extra UE dove il bilancio di carbonio non è stabilito, al fine di presentare il loro cemento come « a basso contenuto di carbonio » evitando le restrizioni normative europee. Attualmente, il settore del cemento « verde » è paragonabile al « Far West »: regna una grande confusione, persino tra i professionisti dell’edilizia. Questa situazione ricorda quella dell’idrogeno per l’aviazione, dove si spera che cementi a zero emissioni di carbonio permettano di proseguire le attività senza modificare le pratiche, i processi o le filiere cementizie che alimentano i cantieri...